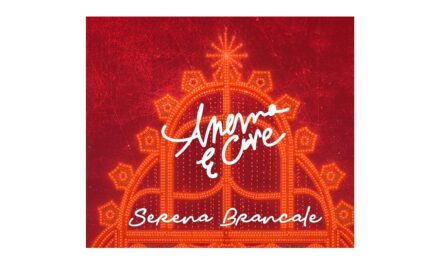IL 2 E 3 SETTEMBRE A PORDENONE I CONCERTI DIRETTI DA MANFRED HONECK CON IL VIOLINISTA RENAUD CAPUÇON
Il 2025 segna una ricorrenza di grande rilievo per la città di Pordenone, il suo Teatro Verdi e la Gustav Mahler Jugendorchester: dieci anni di un sodalizio artistico che ha trasformato un’idea culturale in un punto di riferimento stabile nel panorama sinfonico europeo. Da quel primo, memorabile concerto con Herbert Blomstedt nel 2015, si è sviluppato un progetto capace di intrecciare il talento delle nuove generazioni con la tradizione musicale d’eccellenza, facendo del teatro pordenonese una vera e propria “casa della musica” per oltre 1500 giovani musicisti under 26 e per alcuni tra i più autorevoli direttori d’orchestra internazionali.

Quest’anno la collaborazione si è rinnovata con ben due residenze artistiche: dopo una prima presenza a giugno, i giovani 100 orchestrali della GMJO tornano a Pordenone a metà del mese di 18 agosto, sempre guidati dal direttore assistente Christian Blex e da tutor provenienti dalle più prestigiose orchestre europee, in preparazione del prestigioso Summer tour, una tournée musicale europea che toccherà alcune grandi capitali della musica come Salisburgo, Dresda, Amburgo, Amsterdam, Stoccolma, Bucarest e Praga.
A Pordenone, i concerti del Summer Tour sono in cartellone il 2 e 3 settembre: due straordinari appuntamenti che attraversano le melodie di Korngold, Čajkovskij, Mozart e Bruckner, sotto la bacchetta ispirata del celebre maestro austriaco Manfred Honeck, inconfondibile alchimista del suono, capace di trasformare ogni partitura in un racconto vibrante e profondamente umano. Al suo fianco il violinista Renaud Capuçon, virtuoso dal tocco elegante e dal carisma magnetico. Il programma musicale del concerto di martedì 2 settembre, che fonde armoniosamente lirismo e drammaticità, propone in apertura il Concerto per violino di Korngold, scrittura ricca di melodie evocative e influenze cinematografiche rielaborate in chiave sinfonica, dove si potrà apprezzare tutta l’impeccabile maestria interpretativa di Capuçon, e la Quinta Sinfonia di Čajkovskij.

Genio precoce celebrato da Mahler, Erich Korngold è tra gli ultimi eredi del romanticismo viennese. Nato nel 1897, trovò rifugio negli USA durante l’ascesa del nazismo e divenne figura di spicco nella Hollywood degli anni ’30, firmando celebri colonne sonore per la Warner Bros, vincendo due Premi Oscar e influenzando la musica da film fino alle saghe di Star Wars e Star Trek. Dopo la guerra, tornò alla musica da concerto con il Concerto per violino e orchestra op. 35 (1945), considerato il suo capolavoro. Dedicato ad Alma Mahler, la celebre partitura rielabora temi da sue musiche per film in una raffinata struttura sinfonica. Accanto a Korngold, nel concerto anche la Quinta Sinfonia di Čajkovskij, capolavoro del 1888 costruito attorno al tema del destino, tratto da Una vita per lo Zar di Glinka. Opera intensa e visionaria, è una sintesi magistrale di tensione tragica, lirismo e modernità. Accusata in origine di eccessivo sentimentalismo, oggi è apprezzata per la sua potenza emotiva e per la profondità con cui esprime la lotta dell’uomo contro un fato invincibile. Čajkovskij, definito “ragazzo di vetro” per la sua sensibilità, ha saputo trasformare il tormento interiore in bellezza universale, aprendo la strada a generazioni di compositori del Novecento.
Il concerto di mercoledì 3 settembre propone un raffinato accostamento tra due capolavori della letteratura concertistica e sinfonica. Il Concerto per violino n. 3 di Mozart, affidato ancora a Renaud Capuçon, esalta con una scrittura limpida e raffinata l’eleganza del dialogo tra solista e orchestra. In contrasto, la titanica Nona Sinfonia di Bruckner – incompiuta eppure monumentale – spinge l’orchestra verso estremi di tensione e rarefazione, lasciando la forma sinfonica sospesa tra compimento e abbandono. Un programma musicale che unisce due visioni opposte e complementari della musica: da un lato, la spensierata perfezione di Wolfgang Amadeus Mozart, dall’altro la monumentale profondità spirituale di Anton Bruckner. Il concerto offre un inedito e raffinatissimo confronto tra la trasparenza classica e la vertigine romantica, a suggello di un percorso artistico particolarmente intenso.

Un celebre aneddoto racconta l’esordio di Mozart al violino, ancora bambino, quando stupì i presenti suonando senza esitazione, pur senza aver mai studiato. A 19 anni compone cinque concerti per violino e orchestra, capolavori di equilibrio tra inventiva melodica e dialogo orchestrale. Tra questi, il Concerto n.3 in sol maggiore K 216, brillante e poetico, incarna l’eleganza naturale e la gioia pura della musica mozartiana. In particolare, il movimento lento è stato definito “caduto dal cielo” per la sua serena perfezione. Mozart rifugge dal virtuosismo fine a sé stesso: le sue opere chiedono intelligenza musicale più che mera tecnica. La Nona Sinfonia in re minore di Anton Bruckner rappresenta, invece, l’apice di una visione mistica e grandiosa. Uomo schivo e profondamente religioso, Bruckner, oggi considerato accanto a Brahms e Čajkovskij un pilastro della sinfonia romantica, impiega dieci anni su quest’opera, lavorandovi fino alla morte l’11 ottobre 1896. Le sue architetture sonore, paragonate a cattedrali, uniscono fede, monumentalità e tensione spirituale. La Nona, suo testamento musicale, è uno dei vertici assoluti della musica sinfonica occidentale.