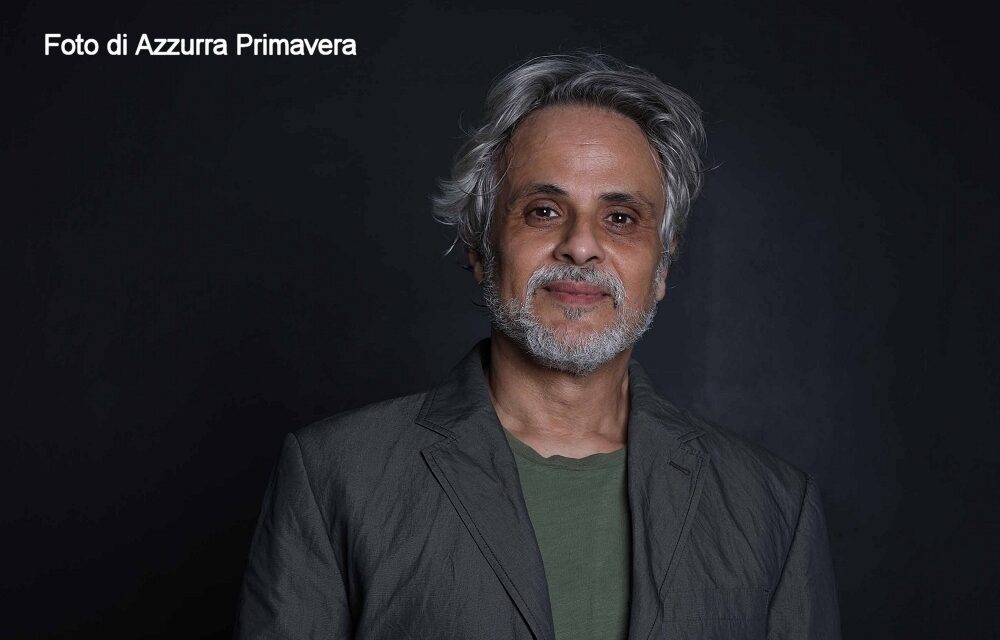C’è bisogno di uno sguardo libero, e soprattutto curioso, per entrare davvero nel mondo di “Quartett”, la pièce appena andata in scena alla Sala Bartoli del Teatro Rossetti. Uno spettacolo che non concede scorciatoie, che chiede attenzione, disponibilità all’ascolto e una certa dose di coraggio interpretativo. Un lavoro stratificato, ricco di rimandi, dove le metafore, mai decorative, parlano anche del nostro presente, delle relazioni di potere, del desiderio e della crudeltà emotiva che spesso lo accompagna. È da qui che nasce questa conversazione con Maximilian Nisi, artista che ama muoversi nei territori complessi del teatro, sia come interprete che come regista e rielaboratore di testi.
Ma chi è MAXIMILIAN NISI?
Un attore che non cerca l’applauso, ma l’incontro. Un uomo che preferisce l’ascolto al rumore. Per me fare teatro è un atto di gratitudine. La mia carriera è un tentativo costante di restituire al Teatro ciò che il Teatro mi ha dato.
Fuori dal palcoscenico ho una natura solitaria e a tratti scontrosa, che si nutre di silenzi e di armonie discrete. Musica, libri, animali, compagni silenziosi di un viaggio che cerca ancora la radice delle cose.

Il suo percorso nasce e si struttura nel teatro, che resta il centro gravitazionale di una carriera attraversata con rigore e curiosità. La formazione si nutre di incontri decisivi: da Giorgio Strehler assimila il senso della poesia scenica, la disciplina del lavoro e quella passione necessaria perché il teatro non sia mai superficie; con Luca Ronconi matura invece una consapevolezza più analitica, comprendendo quanto il rapporto tra un testo e la lingua in cui è stato concepito sia parte integrante della sua verità. Fondamentale anche l’esperienza con Theodoros Terzopoulos, sotto la cui regia interpreta Emone nell’Antigone di Sofocle al Teatro Olimpico di Vicenza, un lavoro che gli vale nel 1995 il Premio Lauro Olimpico e che viene poi portato in tournée internazionale tra Grecia, Cina, Giappone e Corea. Negli anni attraversa produzioni nazionali e internazionali lavorando con registi come Savary, Lavia, Scaparro, Calenda, Cavani, Mauri e, tra le esperienze artistiche più incisive, l’Edipo Re diretto dal russo Anatolij Vassiliev nel 2012, dove affronta il ruolo del titolo. Nel 1997 è protagonista di Billy Budd, regia di Sandro Sequi, prima e unica trasposizione teatrale italiana del romanzo di Melville, che gli vale il Premio Lorenzo il Magnifico. Accanto alla scena, arrivano cinema e televisione, da “Il Partigiano Johnny a “La sindrome di Stendhal”, fino a serie molto popolari come “Un posto al Sole”, “Incantesimo” e “Il bello delle Donne”, senza mai allontanarsi dal lavoro sul testo. Premi, riconoscimenti e l’impegno nella formazione di giovani attori completano un profilo artistico che unisce interpretazione, regia e pensiero teatrale.

Proprio questo suo lungo percorso ci porta a “Quartett”.
Questo spettacolo chiede allo spettatore di entrare in un gioco sottile, fatto di simboli, tensioni e rimandi che non si colgono a una prima lettura. Da dove nasce l’intuizione iniziale di questo lavoro? C’è stata un’immagine, un fascino per il film “Le relazioni Pericolose”, o più per il testo di de Laclos che ti ha dato un input così preciso che ti ha spinto a scavare in questo testo e nelle sue molteplici stratificazioni, fino a farlo divenire tuo e in realtà ricco di metafore che parlano dei giorni nostri, della deflorazione che la vita e gli altri esseri umani che infliggono quotidianamente, tanto sarebbe meglio comprenderlo subito per difendersi?

“Quartett” non è una semplice messinscena, ma un atto di resistenza poetica. Ho cercato di riprodurre il fascino patinato del film e la struttura epistolare del libro di de Laclos. Ho usato le immagini de Le relazioni pericolose come detriti di un mondo esploso. Un lavoro attuale e disperante, una radiografia di un’umanità che si consuma nel desiderio e nel potere, specchio perfetto delle nostre solitudini digitali.
Ringrazio le mie collaborazioni. Per me, il teatro è un’opera corale. E il successo, quando c’è, non è mai personale, ma risiede nella perfezione di un ingranaggio collettivo. Le musiche (Stefano De Meo) che dettano il battito, le luci che scolpiscono il vuoto, i costumi (Vincenzo La Mendola) e le parrucche che non sono travestimento, ma armature emotive. Amo celebrare il teatro come fatto artigianale, dove ogni dettaglio è sacro.
In un mondo che sbiadisce nella volgarità, il mio impegno è quello di salvaguardare la Bellezza. Non come fatto estetico fine a sé stesso, ma come valore etico. La bellezza di un gesto preciso, di una battuta detta con cura, della dignità di un personaggio anche nel momento della sua caduta.

Il tuo lavoro sembra spesso muoversi su un confine delicato: quello tra fedeltà al testo e necessità di renderlo vivo per l’oggi. Quanto è importante, per te, che il teatro non sia mai solo “rappresentazione”, ma anche uno strumento per leggere il presente?
Il teatro non può limitarsi a essere una rappresentazione, ovvero la replica passiva di un testo o di un’epoca, perché diventerebbe un esercizio di vanità museale. Deve essere, invece, una lente d’ ingrandimento posta sopra le piaghe del presente.
La scena deve essere uno strumento di lettura della realtà.
Inoltre non credo che il teatro debba necessariamente consolare. Vedere la propria solitudine o la propria ferocia proiettata su un attore permette allo spettatore di riconoscerla, di darle un nome e, forse, di superarla.
Ed è allora che il teatro diventa strumento quando il pubblico smette di dire “guarda com’erano” e inizia a dire “guarda chi sei”.

Come regista e riadattatore – sceneggiatore di testi, quanto spazio lasci all’istinto durante le prove e quanto invece alla costruzione rigorosa? C’è un momento in cui senti che lo spettacolo smette di essere “tuo” e diventa degli attori?
La regia non è una scelta tra rigore e istinto, ma un processo di sedimentazione. Senza rigore, il teatro è approssimazione. È la griglia che permette all’attore di sentirsi al sicuro.
A volte, in prova, il rigore incontra l’imprevisto e possono accadere cose meravigliose. L’istinto è la capacità del regista di “sentire” quando una verità sta emergendo, anche se non era prevista. C’è un istante magico e quasi doloroso in cui lo spettacolo cessa di appartenere al regista. Accade quando gli attori non eseguono più un comando, ma vivono una necessità. Il gesto non è più ricordato ma è agito. Quando tra gli interpreti e la scena si crea una sintesi tale per cui il Noi prende il sopravvento sull’ Io creativo del regista. Quando l’attore, pur rispettando il rigore della costruzione, inizia a giocare con il pubblico, a gestire il silenzio, a dilatare il tempo, ecco, in quel preciso momento prende il controllo dello spettacolo.

Trieste ritorna più volte nel tuo percorso ovviamente.
Che tipo di dialogo senti di avere con questa città e con il suo pubblico, così attento e spesso molto esigente?
Trieste è una città bellissima che accoglie e che osserva. La sua anima aristocratica e mitteleuropea la rende impermeabile alla vanità e ai facili entusiasmi. Il pubblico triestino è colto, esigente e ha visto passare la storia e i grandi maestri. Se Trieste ti ascolta, significa che hai toccato quel “nervo scoperto” della realtà che la città, per cultura e storia, sa riconoscere.
Ti ho già recensito come attore in “Un autunno di fuoco” di Eric Coble, alla “Contrada” nel 2018. Lì interpretavi un personaggio elegante e disarmante, ma attraversato da fragilità profonde, sempre in bilico tra ironia e disincanto, tra il bisogno di proteggersi e il desiderio di lasciarsi andare davvero. Quanto è stato complesso dare corpo a un uomo che sembra leggero in superficie, ma che nasconde crepe emotive così riconoscibili?
Un artista che si sente fallito porta con sé un senso di lutto perenne: il lutto per la propria immagine ideale. Chris era un pittore. Il suo sguardo sul mondo era diverso; era abituato a osservare le sfumature. Dare corpo a questa sensibilità ha significato lavorare sui dettagli: un’esitazione nel gesto, uno sguardo che si perde, la cura quasi ossessiva per un oggetto. Sono queste le crepe emotive che il pubblico riconosce come proprie.

Il suo rapporto con una madre egotica ha creato una dinamica di attrazione e repulsione paralizzante. Da un lato c’era il bisogno disperato di essere visto e riconosciuto come individuo (e come artista); dall’altro c’era il desiderio di fuggire per non essere schiacciato. È difficile dare corpo a un uomo così. Non si può fingere la fragilità; bisogna trovarla nelle crepe della propria anima. Il fallimento artistico non è assenza di talento, ma impossibilità di far coincidere il proprio mondo interiore con la realtà. Sul palco, questa discrepanza, se ben raccontata, può diventare poesia.

In quello spettacolo il confronto in scena era con una grande interprete.
Che tipo di sintonia si è creata con l’immensa Milena Vukotic, e quanto il dialogo umano, prima ancora che artistico, ha influito sul ritmo e sulla verità dei personaggi?
Con un’attrice della caratura di Milena, la sintonia non si costruisce parlando, ma ascoltando. Esiste un ritmo interno che solo i grandi interpreti sanno sintonizzare. Stare in scena con lei ha significato entrare in una danza fatta di sguardi, di pause e di respiri.
In Un autunno di fuoco, la verità di Chris nasceva dalla capacità di accogliere la leggerezza quasi eterea della madre contrapponendovi densità emotiva.
Lavorare con Milena è un esercizio di grazia. È capire che la potenza del teatro risiede spesso in un filo di voce, purché sia carico di verità umana. Esiste una grande e profonda stima reciproca tra noi anche fuori dal palco.

Passando invece alla regia di “Donne in fuga”, sempre per La Contrada – Teatro Orazio Bobbio, ti sei trovato a dirigere un’attrice che è memoria viva del teatro italiano e della stessa storia della Contrada: Ariella Reggio,di cui ho già fatto la prima parte di una lunga intervista sulla sua vita, ora mi auguro la seconda perché Ariella e cofondatrice, madre putativa della nascita di un Teatro divenuto Stabile come la “Contrada” – “Il Bobbio” che compi 50 anni ad aprile.. È stato più un divertimento, una sfida o un atto di grande responsabilità artistica lavorare con lei?
Dirigere Ariella in “Donne in fuga” ha significato confrontarsi con un’artista che ha contribuito a fondare le mura in cui recita, una donna che possiede quella rara semplicità che soltanto i grandi hanno. Ariella è la “madre putativa” del Teatro Orazio Bobbio, una pioniera che ha trasformato un sogno (La Contrada) in uno Stabile di rilievo nazionale. Per un regista, la sfida è onorare questa storia. Significa avere la cura di chi maneggia un diamante: non devi aggiungergli luce, devi solo creare l’angolazione perfetta perché la sua luce naturale possa colpire.
La sfida non è stata tecnica, ma intellettuale. Ariella ha una conoscenza della scena che precede qualsiasi teoria. Dirigerla richiede un ascolto teso e vibrante. Non si tratta di imporre una visione, ma di costruirla insieme a lei, rispettando il suo istinto infallibile e portando al contempo quel soffio di contemporaneità e rigore che caratterizza il mio concetto di teatro. Inoltre c’è il divertimento puro. Ariella possiede quella freschezza fanciullesca, quel guizzo negli occhi di chi non ha mai smesso di giocare seriamente. Lavorare con lei permette di ritrovare il piacere artigianale del teatro: ridere di una battuta, limare un tempo comico, godere della sua capacità di passare dal registro leggero a quello profondo in un battito di ciglia. E’ stato fantastico!

Tu ti muovi con naturalezza tra recitazione, regia e riscrittura.
Quando affronti un testo non teatrale, un romanzo, un’idea narrativa, una suggestione, cosa ti fa capire che può diventare scena? Qual è la scintilla che ti convince a iniziare una riduzione?
Il passaggio dalla pagina alla scena avviene quando la parola smette di essere raccontata e chiede prepotentemente di essere incarnata. Un romanzo diventa teatro quando contiene un conflitto che non può essere risolto solo dal pensiero, ma che ha bisogno di corpo e voce per esplodere. Se leggendo una suggestione senti che c’è un grido soffocato o una tensione tra due anime che solo lo spazio fisico del palcoscenico può liberare, allora lì c’è teatro. La scintilla è il riconoscimento di una verità umana che scotta troppo per restare intrappolata tra le pagine.
La riduzione che ne verrà non sarà un adattamento, ma una trasfigurazione. È prendere un’idea e darle un battito cardiaco, trasformando la suggestione in un evento che accade qui ed ora.

Ritorniamo a “Quartett”: è un testo che parla di potere, seduzione e manipolazione, ma lo fa senza mai essere esplicito. Quanto ti interessava mettere in luce questi giochi sotterranei e quanto, invece, lasciare che fossero gli spettatori a capirli con la propria sensibilità, perché li stanno subendo o loro stessi sobillano gli altri?
Non desideravo spiegare, ma evocare. Mettere in scena i giochi sotterranei di “Quartett” non significava mostrarli, ma creare un’atmosfera così densa e tesa che lo spettatore non potesse far altro che proiettarvi la propria esperienza. Uno specchio per il pubblico, per intenderci. L’uso di costumi raffinati, di parrucche e di luci studiate non serviva a nascondere il messaggio, ma a renderlo più inquietante. Il fatto che i personaggi non fossero espliciti, che si muovessero in un linguaggio affilato e cerimonioso, avrebbe costretto lo spettatore a guardare sotto la superficie. Se lo spettacolo fosse stato esplicito, sarebbe stato solo cronaca; restando sotterraneo, diventava psicologia.


Non credo sia giusto fornire giudizi morali. Più costruttivo è mettere in scena la danza del potere e lasciare che sia lo spettatore a posizionarsi. Il teatro, a volte, può diventare un luogo pericoloso perché ci obbliga a chiederci: “Da che parte del gioco sono io in questo momento della mia vita?”
Se illumini tutto, non c’è più mistero. Se lasci delle zone d’ombra, lo spettatore le riempirà con i propri mostri.

Nella tua rielaborazione il linguaggio resta affilato, ma mai compiaciuto.
Che tipo di equilibrio hai cercato tra crudezza e misura, tra distanza intellettuale ed emozione?
Il linguaggio è affilato perché deve tagliare i veli dell’ipocrisia. Non ho usato la parola cruda per sconvolgere il pubblico, ma per svegliarlo. La crudezza serve a dare un nome alle cose, al desiderio, alla morte, alla sopraffazione, con la precisione di un bisturi. Se la crudeltà è nel testo, la misura è nell’attore: più il concetto è violento, più il gesto deve essere controllato. Questa tensione trattenuta è ciò che genera la vera emozione.
La distanza intellettuale serve a non far annegare lo spettacolo nel sentimentalismo. È lo sguardo lucido dell’osservatore che analizza il disastro. Questa distanza permette allo spettatore di non sentirsi aggredito, ma invitato a riflettere. È l’eleganza della forma che permette di sopportare l’orrore del contenuto.


E adesso che “Quartett” ha trovato la sua forma e il suo pubblico, dove sta andando la tua curiosità? Quali storie ti stanno girando in testa, quali testi o idee aspettano di essere portati in scena? Se il teatro è ancora, come sembra, il tuo luogo di libertà, da quale porta pensi di entrare la prossima volta?
Mi piacerebbe continuare il dialogo con le grandi memorie del teatro ma anche spalancare le finestre sui giovani. La libertà qui risiede nel veder fiorire il talento altrui, nel trasformarsi definitivamente in quel catalizzatore che permette alla bellezza di accadere, scomparendo come individuo per riapparire come visione collettiva. C’è poi la porta della riscrittura. Cercare quella suggestione letteraria ancora muta, quel romanzo o quel diario che nessuno ha mai osato portare in scena, e trasformarlo in un atto teatrale. Entrare dalla porta dell’autore per riscattare un nervo scoperto della nostra contemporaneità che aspetta ancora di essere nominato. Entrerò da quella porta dove il silenzio è più denso, perché è lì che la parola può risuonare più vera.